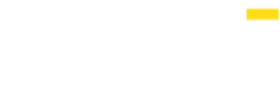Intervista a Francesco Vezzoli
L’arte è da sempre capacità di trasfigurare le emozioni, di distillarle e sublimarle fino a renderle simboli, visioni, tracce tangibili. Una dinamica che emerge con forza nello scatto Larmes de Verre (1932) di , in cui le lacrime cristallizzate adagiano sul volto enigmatico di una modella. Sul grande schermo, invece, parlano direttamente all’animo umano il pianto magnetico di ne La passione di Giovanna d’Arco (1928) di Carl Theodor Dreyer e quello straziante di Sophia Loren ne La ciociara (1960) di Vittorio De Sica. Facendo incontrare memoria iconografica e processo creativo, ‒ uno degli artisti italiani più acclamati a livello internazionale ‒ ha interpretato, con un approccio giocoso ma sofisticato, questo fragile territorio. Nel circuito delle immagini, così come nel vortice della vita, sono i dettagli a fare la differenza: dalla loro somma affiora un’identità. Vezzoli interviene su una selezione di volti hollywoodiani, facendo sgorgare dai loro occhi vistosi rivoli ricamati, senza però ridurli a immagini di pura sofferenza. Un’operazione indelebile che ‒ come una sorta di pop art 4.0 ‒ invita a guardare oltre la superficie scintillante della cultura visiva. Le lacrime trasformano, pertanto, la figura della celebrità ‒ da sempre emblema di perfezione ‒ in una presenza vulnerabile e umana: il ricamo diventa uno strumento capace di sovvertire l’ideale del mito impeccabile. Da questo progetto nasce una galleria di facce d’autore che compongono Diva?, volume edito da e curato da Shai Baitel, dedicato all’universo dell’artista bresciano, fatto di sentimento, ricerca, stupore ed energia. «A me sembrava che queste foto, nella loro perfezione, avessero bisogno di un bilanciamento, in qualche modo, per la mia sensibilità, e quindi da qualche parte dovesse emergere una forma di verità», osserva Vezzoli, chiarendo come per lui proprio quel taglio, quel segno manuale, apra una feritoia sul reale.
1
Rispondi sempre malvolentieri alla domanda su come sia nata questa bizzarra ossessione, vero?
Sì, è notorio, ma soltanto perché non ho una risposta. Posso spiegare concettualmente perché ho scelto di filmare dentro la casa di con una canzone di : c’è un legame concettuale con un film di , dove anche lui utilizza un suo brano, più che con i mille altri legami logici, concettuali o, a volte, illogici che attraversano i miei lavori. Queste lacrime rappresentano la parte più irrazionale e sentimentale; e forse è così anche dentro di me: come persona che fa progetti, ho una parte razionale e concettuale e poi una parte sentimentale, e queste lacrime la esprimono. Qualunque altra spiegazione mi rivelerebbe troppo e mi turberebbe.
Cosa rappresenta per te la lacrima?
Ho fatto anche una mostra che si chiama Musei delle lacrime, perché le lacrime sembrano non esistere nella storia dell’arte, mentre compaiono in tutte le altre discipline artistiche, non solo nel cinema, che è l’arte predominante del Ventesimo secolo. La lacrima diventa il parametro in base al quale si misura l’eccellenza di un prodotto artistico: un film è un capolavoro perché “fa piangere”; un’attrice è bravissima perché “piange in maniera incredibile”. La lacrima è sempre un picco del sentimento, sia per chi guarda sia per chi si fa vedere: dentro la dialettica cinematografica è, paradossalmente, un termometro dell’emozione. L’arte ‒ quella che dovrebbe, o che nella storia ha comunque rappresentato uno specchio delle passioni e dell’identità umana ‒ a un certo punto ha cancellato le lacrime, o quantomeno sembra non averle mai davvero accolte. Per me, inserirle è stato naturale.
La tua ricerca si nutre anche del piacere di contaminare, sparigliare le carte e mettere a soqquadro, senza però generare disarmonia, soltanto bellezza. Come affronti questo processo creativo?
Faccio tutto in funzione di quello che, per me, rappresenta un dibattito concettuale e artistico interno al mio mondo lavorativo. Nel momento in cui scelgo un brano per un video, realizzo un finto trailer per un ipotetico remake di Caligola di o ricamo una lacrima, compio in maniera consapevole un gesto che è una risposta a ciò che non ho trovato nei gesti degli altri. Non provo alcun disprezzo per il lavoro altrui, sia chiaro, ma penso che le letture del camp, del queer e del kitsch siano un po’ dimenticate. Tieni conto che la mia formazione è avvenuta a Londra negli anni Novanta, e che quell’immaginario alla Raffaello Matarazzo, alla Douglas Sirk, alla Pedro Almodóvar era materiale emotivo molto più navigato nel mondo del cinema che in quello dell’arte. Nei quadri di , per esempio, non c’erano le lacrime, e neanche nei suoi film.
La matrice della tua produzione è la libertà di pensare e di progettare tutto ciò che desideri. Cosa vuol dire essere un artista libero?
Sono un uomo libero. Quando sono andato al primo giorno di catechismo c’è stato un conflitto tra me e l’educatore ‒ credo avessi otto anni ‒ perché aveva impostato tutta la lezione sulla verità, sulla bugia e sulla confessione. Io dissi che non capivo, perché non dicevo mai nessuna bugia, e da lì nacque un conflitto tra me e lui. Sono tornato a casa e ho detto ai miei genitori che non avrei fatto la prima comunione, perché tutto mi sembrava basato su una negoziazione tra la verità di un’identità “scolastica” e la verità di un’identità “teppistica”. Dentro di me non c’è mai stata questa scissione, come non c’è mai stata neanche nell’identità sessuale. Non mi sono mai sentito non libero, se non in alcune fasi della vita in cui, però, ho provveduto rapidamente a liberarmi delle prigionie.
Il dialogo con ha dato vita a una mostra inedita, dove le sue immagini archeologiche hanno incontrato la tua interpretazione. Che cosa ti ha lasciato quell’esperienza?
Mi ha lasciato un patrimonio umano, perché penso che Mimmo fosse molto di più di quanto si sia ancora capito. È stato un grandissimo fotografo e documentatore di momenti storici fondamentali della storia artistica italiana. Penso, ad esempio, a un libro come Chi è devoto?, in cui si reca in tutti questi paesi dell’entroterra campano e documenta riti in cui, peraltro, sono presenti la fluidità di genere e tutta una serie di rapporti con la religione e con la sessualità. Mimmo Jodice è stato una sicurezza per me. Ma c’era anche un aspetto molto umano: non mi è mai capitato di conoscere una famiglia d’artista così speciale. Ne ho conosciute tante, molto più disperate; ma il nucleo Iodice è una bellissima entità affettiva.
Nel libro Diva? fai riferimento al punto di domanda come chiave di lettura. Che ruolo gioca questo simbolo nel mondo dell’incertezza?
Il punto interrogativo è stato un’idea del grafico che ha curato il libro ed è diventato una chiave di lettura molto interessante. La risposta, dal mio punto di vista, è semplice. Oggi, se vai da qualunque uomo o donna ‒ da , da persone che hanno lavorato con me o dalle grandi attrici italiane ‒ nessuna vorrebbe sentirsi chiamare diva. La parola diva viene associata a qualcosa di frivolo, autoriferito e non politicamente corretto. Evidentemente tutti gli attori, per una strana mimesi o legge del contrappasso, si sentono in dovere di comportarsi come fari dell’etica. In realtà, la storia dell’entertainment ci racconta ben altro: Hollywood negli anni Venti o Cinquanta era assolutamente scellerata. Pare quindi che, per il divismo, nel teatro e nel cinema non ci sia più posto ‒ e nemmeno nello sport. Tutti sono virtuosi, nessuno vuole più avere l’onestà intellettuale di dichiarare un po’ la propria vanità, e quindi di essere un po’ diva. Questo divismo si è spostato tutto dentro i social media, dove persone che non hanno un credito attoriale o una dimensione professionale di altro genere mettono in scena comportamenti del divismo del passato.
A proposito di dive: eri legatissimo a , un simbolo della Milano che ha reso grande l’Italia.
Ci siamo conosciuti molto tardi nella sua vita e molto recentemente nella mia. Posso dire, però, di averla conosciuta artisticamente da sempre e di averla amata da sempre; quindi, più che di un’influenza, parlerei di una compagnia, qualcosa di unico. Penso che la musica popolare ‒ e l’ho spiegato in tanti dei miei progetti ‒ abbia un ruolo fondamentale nella cultura, anche se in certi momenti è stata un po’ disconosciuta. Ornella, in questo senso, lo è stata, e probabilmente per il Ventesimo secolo italiano, considerando anche che, rispetto a , ha voluto e accettato di rimanere sulle scene fino alla fine, è stata probabilmente la più grande sotto tanti punti di vista. È un esempio di capacità continua di reinventarsi.
Francesco, sei uno di quegli artisti che spera attraverso l’arte di trovare soluzione ai problemi?
Assolutamente no.
Finirai sui libri di storia come il maestro delle lacrime o per qualche altro colpo di genio che dobbiamo ancora scoprire?
Non sappiamo cosa ci riserverà la storia, anche perché io non ci sarò. Il “maestro delle lacrime” è solo una battuta ironica, come un tempo c’erano il maestro dei tappeti o il maestro degli arazzi. E, tra le risate, posso dirlo chiaramente: di quello che sarà di me quando non ci sarò più non me ne importa nulla.
Immagine: Cary Grant e Grace Kelly (foto per gentile concessione di Skira)
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata